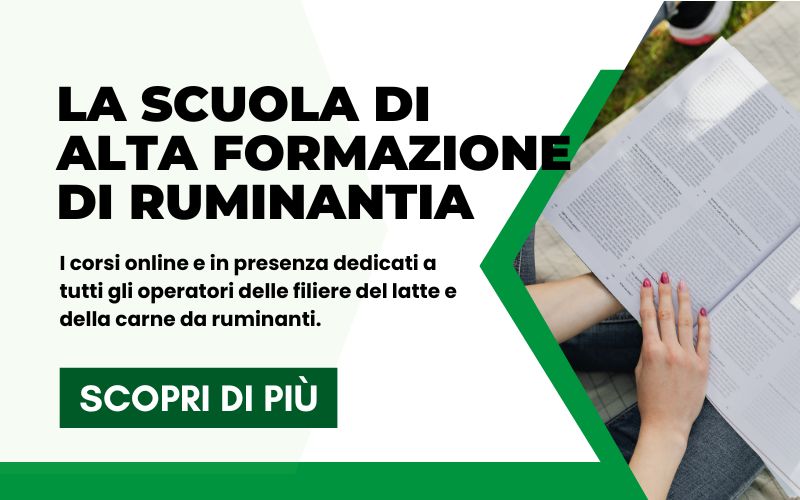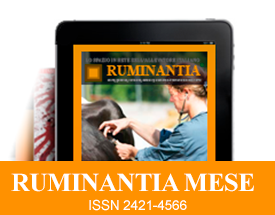Uno dei fondamenti della nutrizione dei ruminanti è la possibilità di regolare il pH all’interno del rumine. Questo parametro, spesso sottovalutato, rappresenta un nodo cruciale per garantire una fermentazione efficiente, la crescita ottimale della flora microbica e, in ultima analisi, la massima produzione di proteina metabolizzabile disponibile per l’animale.
Il ruolo della flora ruminale
La microflora del rumine svolge un compito straordinario: fermenta i carboidrati ingeriti producendo acidi grassi volatili (AGV), che sono la principale fonte di energia per il ruminante. Inoltre, la biomassa microbica che si sviluppa rappresenta una fonte proteica di altissimo valore, specialmente quando la dieta è ben bilanciata tra proteine degradabili e by-pass.
Per massimizzare questa produzione, è necessario “spingere al massimo il fermentatore“, ovvero mettere il rumine nelle condizioni ideali per sviluppare una flora microbica attiva ed efficiente. Questo avviene fornendo carboidrati (sia fibra che amido) nella quantità e nella forma più degradabile possibile. Tuttavia, questa strategia comporta un aumento nella produzione di AGV, che abbassa il pH ruminale. Quando questo scende sotto la soglia critica di 5.5, si apre la porta all’acidosi, con effetti potenzialmente dannosi sia a breve che a lungo termine.
La gestione dinamica del pH
Durante la transizione dall’asciutta alla lattazione, il pH ruminale tende a ridursi fisiologicamente. Questo processo è accettabile solo se avviene in modo graduale e controllato, altrimenti può innescare squilibri metabolici.
Questa transizione viene influenzata da tre fattori chiave:
-
Qualità della fibra: migliorare la digeribilità dell’NDF con buone pratiche agronomiche e tecnologie di raccolta.
-
Sostituzione parziale dei foraggi: impiegare fibre da concentrati più degradabili.
-
Incremento dell’amido: sostituire parte dell’NDF con amidi rapidamente fermentescibili.
Queste strategie, però, vanno dosate con cautela. L’amido alimenta la flora amilolitica, che prospera in ambiente acido, ma inibisce quella cellulosolitica, essenziale per la digestione della fibra. Il risultato? Un rumine che lavora a doppia velocità, con il rischio di sbilanciare la produzione di AGV e compromettere la salute dell’animale.
Il ruolo tampone della saliva
La saliva rappresenta il principale meccanismo tampone del rumine. Contiene fosfati e bicarbonati che neutralizzano gli acidi prodotti durante la fermentazione. La produzione salivare è direttamente legata alla masticazione, sia durante l’ingestione che la ruminazione. Meno fibra strutturata significa meno masticazione e meno saliva, quindi pH più basso.
Ogni punto percentuale di fibra (ADF) in meno nella dieta corrisponde a un calo di circa 0,056 unità di pH ruminale. Il range ottimale per la digestione della fibra si colloca tra pH 6.4 e 6.8. Sotto questi valori, la flora cellulosolitica rallenta e il grasso del latte tende a calare, specialmente quando il rapporto tra acido acetico e propionico scende sotto 2:1.
Produzione di AGV: un equilibrio delicato
Con l’attuale intensificazione dell’allevamento e l’uso di maggiori quantità di concentrati, la produzione giornaliera di AGV può raggiungere i 7.600 grammi per vacca, ossia 160 moli al giorno. La loro assunzione nel sangue avviene in gran parte (85%) per assorbimento epiteliale. Tuttavia, questo processo comporta una liberazione di ioni H⁺ che, se non correttamente tamponati, causano acidificazione.
Il sodio, necessario per lo scambio ionico H⁺/Na⁺, deve quindi essere presente in quantità adeguate nella razione. Le raccomandazioni parlano di almeno lo 0.18% della sostanza secca sotto forma di sodio.
Cicli ruminali e produzione salivare
Una bovina in lattazione passa circa 12 ore al giorno tra ingestione e ruminazione. Durante i 14 cicli ruminali quotidiani, vengono prodotti in media 170 litri di saliva, con picchi fino a 300 litri. Questo flusso continuo è essenziale per stabilizzare il pH e garantire il corretto funzionamento del rumine.
Fattori di stress ambientale, come il caldo, possono ridurre la disponibilità di bicarbonato (a causa della perdita di CO₂), limitando la capacità tampone. È per questo che l’uso di tamponi aggiuntivi come il bicarbonato di sodio (0.7–1% della SS) è prassi consolidata in molte razioni.
Linee guida pratiche per stabilizzare il pH ruminale
Per mantenere il pH entro un intervallo sicuro e garantire un’efficace fermentazione, ecco alcune raccomandazioni chiave:
- Scelta dei foraggi: prediligere l’alta digeribilità dell’NDF (DNDF) – La digeribilità della fibra (DNDF) è un parametro essenziale perché determina quanto della fibra ingerita verrà effettivamente fermentata nel rumine. Più è digeribile, più efficiente sarà la produzione di acidi grassi volatili (AGV) e di biomassa microbica, senza però prolungare eccessivamente il tempo di ritenzione nel rumine. Gli insilati, rispetto ai fieni secchi, hanno generalmente una maggiore disponibilità fermentativa e un contenuto di NDF più “attivo”. Inoltre, sono più stabili in termini di umidità e composizione, riducendo i rischi legati alla variabilità qualitativa.
- Leguminose vs Graminacee: la superiorità tampone dell’erba medica – Le leguminose come l’erba medica possiedono una maggiore capacità tampone rispetto alle graminacee. Questo significa che riescono a neutralizzare meglio gli acidi prodotti durante la fermentazione ruminale, mantenendo il pH più stabile. Ciò è dovuto al loro maggiore contenuto in proteine e minerali (soprattutto potassio), che partecipano attivamente all’equilibrio acido-base. Tuttavia, va gestita con attenzione per evitare eccessi proteici e squilibri nella fermentazione.
- Struttura della fibra: ruolo cruciale della peNDF – La fibra fisicamente efficace (peNDF) è quella frazione di NDF che ha dimensioni tali da stimolare la masticazione e quindi la produzione di saliva, il principale tampone naturale del rumine. Mantenere almeno il 20% di peNDF sulla SS, con una granulometria corretta (6-10% di particelle >1.2 cm e 30-50% >0.9 cm), è fondamentale per indurre una ruminazione attiva. Se la fibra è troppo corta o troppo fine, la bovina mastica meno, produce meno saliva e il pH ruminale scende, con rischio di acidosi subclinica.
- Unifeed equilibrato: evitare la selezione dei concentrati – La capacità delle bovine di selezionare gli alimenti nel carro unifeed è uno dei principali fattori di rischio per l’instabilità del pH. Se riescono a “scegliere” i concentrati, li consumeranno in eccesso rispetto alla fibra, con un picco fermentativo rapido e produzione acida sbilanciata. Un mix ben miscelato e umido al punto giusto (non polveroso, né troppo secco) impedisce la selezione e garantisce una fermentazione più costante.
- Suddivisione dei pasti: meglio piccoli pasti frequenti – Fornire grosse quantità di concentrati in un’unica somministrazione è uno degli errori più frequenti. Il rilascio rapido di amido comporta una produzione massiva di AGV in poco tempo, e il rumine non riesce a compensare con assorbimento e tamponamento. Meglio frazionare i concentrati durante la giornata, in 3-4 somministrazioni o, idealmente, distribuirli uniformemente nel TMR.
- Stimolare la ruminazione: l’importanza del fieno trinciato – Nelle razioni tradizionali (non unifeed), l’utilizzo di fieno trinciato può stimolare la ruminazione grazie alla sua struttura più lunga, che induce la masticazione. Anche se non ha un elevato valore nutritivo, il suo effetto meccanico sulla salivazione è determinante per l’equilibrio ruminale. La ruminazione attiva è anche un ottimo indicatore di benessere.
- Acqua sempre disponibile: soprattutto dopo la mungitura – Il fabbisogno idrico delle bovine è elevato, ma aumenta in modo critico subito dopo la mungitura, quando si verifica la massima ingestione di sostanza secca. L’acqua è essenziale per il corretto funzionamento del rumine: diluisce gli acidi, facilita il passaggio digerente e favorisce la produzione di saliva. Fonti pulite e facilmente accessibili sono fondamentali.
- Comportamento fisiologico: rispettare i ritmi naturali – Una bovina dovrebbe poter dedicare almeno 11-12 ore al giorno tra alimentazione e ruminazione, con circa 9–11 pasti e 14 cicli ruminativi giornalieri da almeno 30 minuti ciascuno. Quando questi ritmi vengono alterati (ad esempio da sovraffollamento, caldo, gestione errata del tempo in sala mungitura), la ruminazione cala e con essa la produzione di saliva, portando a un aumento del rischio di acidosi.
- Bilancio elettrolitico (DCAD): da non trascurare anche in lattazione – Il DCAD (Differential Cation-Anion Diet), espresso in meq/100g SS, agisce sull’equilibrio acido-base della bovina. Valori tra 35-40 meq/100g migliorano l’ingestione, la produzione di latte e grasso e contribuiscono alla stabilità del pH ruminale e del sangue. Anche se usato di routine in fase di asciutta, è altrettanto utile in lattazione. Bicarbonato e fonti di potassio sono i principali strumenti per bilanciare la razione.
- Proteina rumino-degradabile: il giusto apporto – Per supportare una flora microbica efficiente, è necessario fornire almeno l’11% della sostanza secca sotto forma di proteina rumino-degradabile (RDP), di cui almeno il 5% solubile. Questa quota è utilizzata direttamente dai microrganismi per crescere e proliferare, producendo biomassa microbica che sarà poi digerita nell’intestino come fonte di amminoacidi metabolizzabili. Un deficit proteico rallenta la fermentazione della fibra.
- Uso di additivi naturali: l’effetto dell’Aspergillus oryzae – L’Aspergillus oryzae è un additivo naturale che stimola la crescita della flora cellulosolitica, particolarmente sensibile ai cali di pH. Migliora la degradabilità della fibra e può essere decisivo quando si utilizzano foraggi di bassa qualità o in condizioni in cui la quota di fibra efficace è ridotta. Il suo utilizzo contribuisce anche ad aumentare il tempo di permanenza del foraggio nel rumine, migliorando la fermentazione.
Conclusione: il delicato equilibrio tra energia e stabilità
L’obiettivo è sempre lo stesso: massimizzare la produzione di energia e proteina metabolizzabile senza compromettere la salute del rumine. In un contesto in cui la qualità dei foraggi può variare a causa di condizioni climatiche difficili, è necessario ricorrere a fonti alternative di NDF (come polpe, cruscami, buccette di soia) e integrare con tamponi ben dosati.
Il segreto sta nel mantenere un equilibrio dinamico tra carboidrati strutturali e non strutturali, tra amidi e fibra, tra acidità e capacità tampone, garantendo che ogni boccone ingerito sia una leva per la salute e la produttività della vacca.