Durante il periodo che va dal Settembre 1944 al Maggio del 1945, verso la fine della seconda guerra mondiale, i Tedeschi interruppero il trasporto di cibo e di carburante verso i Paesi Bassi, specialmente nelle densamente popolate province occidentali, abitate da 4.65 milioni di persone. Questo embargo, unito ad un inverno particolarmente rigido, provocò la morte di 18.000 olandesi. Oltre a questo si verificò un fenomeno piuttosto strano. Una carestia inedita e così grave in una popolazione occidentale, oltre alla pietà e all’orrore, stimolò la curiosità degli scienziati che cercarono di verificare se una privazione di cibo così intensa e protratta e lo stress ambientale dovuto dal gran freddo avrebbe potuto ripercuotersi negativamente sulla salute sia dei sopravvissuti che dei bambini concepiti durante questo periodo di circa 9 mesi. Gli epidemiologi notarono, dai numerosi studi di corte effettuati, che la carestia olandese provocò un aumento del rischio di obesità, ipertensione, diabete tipo 2 e disturbi psicopatologici tipo depressione e schizofrenia nei soggetti esposti alla carestia materna in epoca fetale rispetto ai soggetti nati nel periodo precedente e in quelli nati nel periodo successivo. Patologie che sarebbero comparse in età adulta e quindi decine e decine di anni dopo la nascita.
Darwin, con la sua “Teoria dell’evoluzione” e la pubblicazione nel 1859 del libro “L’origine della specie”, rivoluzionò tutti i paradigmi allora esistenti dimostrando che le varie specie si evolvono per meglio adattarsi all’ambiente, ovvero alle innumerevoli “nicchie ecologiche” di cui è composto il nostro pianeta. Nell’ambito delle specie, per mutazioni casuali del DNA nascono individui sempre più adatti ad un ambiente che è anch’esso in evoluzione. E’ quindi evidente che le specie più “forti” sono quelle più adattabili e che la presenza dei polimorfismi genetici conferisce un indubbio vantaggio evolutivo a chi li possiede. La scienza che studia questo fenomeno, che non è più la “teoria di Darwin” ma una legge, sia chiama biologia evolutiva. L’ambiente e la sua mutevolezza esercitano sulle specie una pressione costante, “premiando” quegli individui che posseggono geni che inducono fenotipi più adatti. La selezione genetica permette quindi ad una specie di adattarsi meglio all’ambiente. A testimonianza di questo, le tante specie e razze che si sono estinte.
Nel nostro ambito zootecnico basta osservare come le numerose razze bovine di oggi si siano differenziate dal progenitore Uro a causa della pressione selettiva esercitata non tanto dalla natura quanto dall’uomo. Sempre sorprendente è la meticolosità della natura nel garantire alle specie, ma anche, e soprattutto, agli individui che le compongono, tutte le possibili opportunità per meglio adattarsi all’ambiente con l’obiettivo primario di riprodursi, perché a ciò si riconduce il concetto di “essere adatto”. Prima che Darwin presentasse la sua teoria dell’evoluzione, Jean-Baptiste de Lamarck affermava che “le specie si evolvono perché l’ambiente modula la fisiologia dei singoli individui e ciò è trasmissibile alle future generazioni”. La teoria di Darwin oscurò completamente il pensiero di Lamarck ma nel 1942 Conrad Hal Waddington cominciò a parlare di epigenetica, ossia di come l’ambiente potesse modificare non solo la sequenza dei geni ma la loro espressione. L’epigenetica spiega perché individui con una sequenza genetica simile se non uguale (cloni) possono esprimere fenotipi diversi.
Quello che era successo durante la “carestia olandese” è che le madri così gravemente private di cibo e così sottoposte ad un gran freddo avevano dotato la prole che portavano in grembo di una maggiore capacità di sopravvivenza una volte venuta alla luce, non potendo ovviamente sapere quando sarebbe finito il freddo e la carestia. L’aumento della prevalenza delle gravi patologie osservata sugli adulti concepiti durante la carestia altro non era che il frutto di un riassetto metabolico che la madre aveva indotto sulla sua prole per dargli una maggiore chance di sopravvivenza.
Ma come fa l’ambiente materno, soprattutto nutrizionale, ad influenzare non la sequenza genetica ma l’espressione dei geni? Sappiamo che tra la madre e il feto, attraverso la placenta, avviene uno scambio di ormoni, nutrienti e metaboliti ma anche di inquinanti. Queste molecole possono inibire o consentire l’espressione di determinati geni ritenuti più funzionali all’individuo per il suo adattamento all’ambiente in cui dovrà vivere. Questa modulazione nell’espressione o inibizione di determinati geni avviene sostanzialmente attraverso specifici meccanismi biochimici che agiscono sul DNA, come la metilazione, l’acetilazione, l’ubiquitazione e la fosforilazione. Il meccanismo più importante e più noto è quello della metilazione, ossia il trasferimento di un gruppo metile dalla s-adenosilmetionina (SAM), considerata il donatore universale dei gruppi metilici, alla citosina (nucleotidi citosina-guanina o CpG) dell’acido desossiribonucleico (DNA). Questo trasferimento può persistere anche durante i meccanismi di duplicazione del DNA (mitosi e meiosi) e può quindi essere trasmesso alla discendenza. Un altro meccanismo epigenetico importante sono le modifiche post-traduzionali dell‘istone. Le proteine dell’istone sono elementi strutturali del nucleosoma, sono basiche, costituiscono la componente strutturale della cromatina e sono costituite prevalentemente di lisina e arginina. La funzione degli istoni è quella di organizzare il DNA compattandolo in maniera ordinata. L’acetilazione della coda dell’istone allenta le interazioni istone-DNA consentendo l’accesso selettivo al DNA per la trascrizione. Gli istoni posso essere oggetto di acetilazione, ossia il trasferimento di un gruppo acetile dall’acetil-CoA, oppure di metilazione, per trasferimento di un gruppo metilico dalla SAM alla lisina o all’arginina presenti nell’estremità n-terminale.
In conclusione, anche influenze nutrizionali o ambientali transitorie sul feto durante la gravidanza possono produrre cambiamenti di tipo epigenetico persistenti per tutta la vita dell’individuo e trasmessi alle generazioni successive. Nella biologia evolutiva e nell’epigenetica umana uno dei loci più studiati è quello che esprime il fattore di crescita insulino-simile IGF-2, un fattore chiave per lo sviluppo.
La vicenda della carestia olandese e la conoscenza dell’epigenetica stimolano un’inevitabile riflessione sull’allevamento della bovina da latte, ma anche delle altre specie di ruminanti domestici, come la capra, la bufala e la pecora da latte. Uno dei paradigmi più consolidati è che la bovina da latte per essere più redditizia possibile deve fare nel corso del suo ciclo produttivo più lattazioni possibili e per questo deve ingravidarsi il più rapidamente possibile dopo il parto. Una sorta di selezione naturale sta selezionando probabilmente le bovine da latte non fertili “premiando” quelle in cui il punto più basso del bilancio energetico e proteico negativo coincide di meno con il periodo ideale per la fecondazione. Si osserva ormai negli allevamenti di frisone come il picco di lattazione sia sempre più lontano dal parto e come stia aumentando la persistenza della lattazione anche nelle pluripare. L’unico modo in cui la selezione genetica può svolgere la sua fondamentale funzione è proprio escludendo l’individuo “meno adatto” dalla riproduzione.
Si ritiene ancora ideale avere un intervallo tra il parto e il concepimento che tende ai 100 giorni. Per arrivare a questo obiettivo, è necessario che la bovina venga fecondata dopo il parto il più precocemente possibile, visto che il tasso di concepimento nei primi calori dopo il parto è abbondantemente al di sotto del 50%. Secondo i dati dell’Ufficio Studi di AIA, la frisona italiana fa il picco di lattazione a circa 90 giorni e le bovine con una produzione maggiore di 40 kg sono all’incirca il 17%, anche se negli allevamenti molto produttivi questa percentuale sale ad oltre il 40%. Con gli alimenti e gli additivi utilizzabili in Europa e la digeribilità dei foraggi che realisticamente possiamo produrre è difficile che una dieta possa “coprire” produzioni superiori ai 40-45 kg, per cui per molte settimane dopo il parto le bovine si trovano in una condizione di bilancio energetico e proteico negativo. Ne è testimonianza il più o meno accentuato calo di peso corporeo e la percentuale spesso superiore al 20% di bovine di razza frisona che in questo periodo persistentemente hanno una proteina del latte < 2.90%. Anche se le evidenze scientifiche sono poche, è ragionevole immaginare che durante le prime settimane di lattazione ci sia anche un bilancio negativo dei gruppi metilici (NMDB). E’ pertanto giustificato supporre che le bovine da latte nelle prime settimane di lattazione, e quindi anche nel periodo del concepimento e nelle primissime settimane di gravidanza, si trovino in una condizione di bilancio energetico negativo (NEBAL), di bilancio proteico negativo (NPB) e di NMDB. Questo status si potrebbe anche estendere ad alcune vitamine, ma ad oggi le evidenze scientifiche sono insufficienti. Questi assetti metabolici, se gravi, e quindi clinici, possono rendere la bovina non fertile, sia permanentemente che temporaneamente, mentre se sono più lievi possono agire epigeneticamente sul DNA, specialmente nelle bovine “forzate” a riprodursi con le sincronizzazioni ormonali come Ovsynch e similari. L’aver sottovalutato gli effetti “devastanti” che può avere l’epigenetica su una razza d’allevamento può essere anche alla radice della difficoltà che si hanno oggi nell’allevare le bovine da latte.


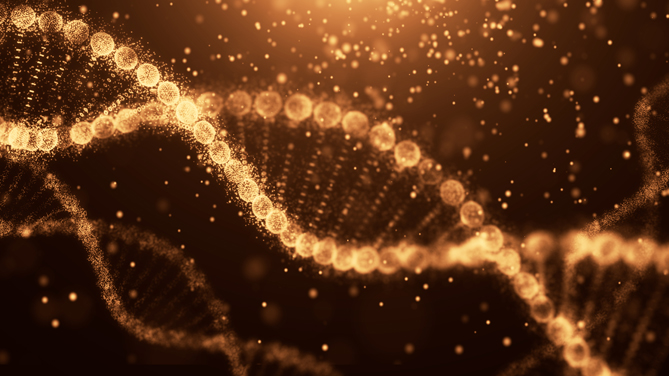





Scrivi un commento
Devi accedere, per commentare.